.
Il “come eravamo” di Cosimo Formichella è la fotografia nitida ed eloquente di un’identità perduta che la modernità ha cancellato dalla memoria di tutti i solopachesi. Non che si voglia rimpiangere il tempo passato rivendicandone la restaurazione – sarebbe da schiocchi! – ma, più concretamente richiamare alla memoria il tempo ed i costumi andati è un’operazione di recupero culturale alla quale auspicabilmente dovrebbero dedicarsi tutti coloro i quali tengono alla preservazione del tempo che è stato e della loro storia per non perdere il legame con le radici sulle quali il presente ed il futuro dovrebbero essere costruiti. Purtroppo le cose non vanno così. E ce lo ricorda l’ utile e suggestivo volume di Formichella raccontandoci che cosa era la nostra comunità di fronte alla quale scorgo i segni dell’indifferenza. Tradizioni popolari in Solopaca non è soltanto la raccolta dei ricordi di come ci si portava e di come si viveva in epoche ormai lontane nella nostra terra, ma un richiamo, di grande spessore, agli elementi costitutivi di una comunità viva e vitale che oggi sembra agonizzante dal momento che la memoria in essa non agisce più, come se fosse un’anticaglia inservibile, un utensile consumato.
di Gennaro Malgieri
Raccogliamo dal ricco racconto delle consuetudini ingiallite che Formichella, con gusto narrativo ed eleganza stilistica, oltre che con storica puntualità, propone da un lato la “curiosità” nel conoscere ciò che è stato attraverso le tradizioni elementari, da quelle civili a quelle private, e dall’all’altro ad “attizzare” il piacere della memoria non soltanto come divertissement , bensì come “dovere” di un aggregato umano che malauguratamente va sgretolandosi proprio perché il ricordo non viene più coltivato. Non si tratta, con tutta evidenza, di un fenomeno che riguarda soltanto la nostra terra, ma è pressoché “universale”. Per il semplice fatto che nostro è il tempo dell’oblio.
Sulle nostre strade incontriamo i segni che ci sembrano afoni perché non riusciamo ad ascoltarli. Sono patrimoni la cui eredità nessuno reclama. Stanno lì, ai margini dell’indifferenza, residui di epoche vicine e lontane che non hanno la forza di attrarre l’attenzione del passante ipnotizzato da un orizzonte indecifrabile.
–
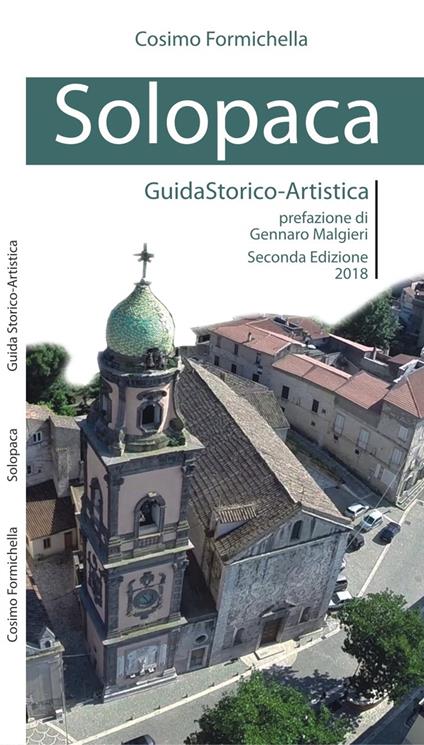
.
Con le pietre del passato, ci viene detto, non si costruisce nulla. I materiali che si preferiscono impiegare sono altri: meno resistenti, più economici, maggiormente malleabili. Destinati a un deperimento precoce, tanto per non avere l’incombenza della custodia, del restauro, della manutenzione. E scolora così, nella dimenticanza, il debito tramandatoci da chi ha attraversato il tempo prima di noi.
Seppur s’eclissa la bellezza, resta il suo simulacro nell’abbandono cui ci dedichiamo recitando estetizzanti mantra che esaltano l’effimero come destino, tra le cui amorevoli braccia, si dice, inevitabilmente troveremo la quiete. Neppure l’arte o la musica resistono al vento della corruzione: persistono fino a che dura il lamento, ma non si riproducono nell’aridità di anime sfinite dall’estenuante opposizione alla depredazione di ciò che le rendeva ricche, feconde, seducenti.
L’oblio sta vincendo la sua partita sulla memoria e trafuga qualsiasi cosa non abbia a durare lo spazio di un banale utilizzo. Economizzare il piacere o il peccato, la virtù o il vizio, la gioia o il dolore è indifferente. Ricordare è verbo da espungere, come accennavo, dal vocabolario della modernità. Perché insopportabilmente osceno di fronte all’infinito nulla cui deve ridursi la vita affinché non abbia obblighi verso la morte e dunque nei confronti della posterità. L’attimo è l’interruzione continua di un sentiero. Come un verso che non si ritrova con il successivo.
Uccidere la memoria equivale a svaligiare il futuro. La sua essenza, infatti, non è tanto quella di rinnovare il passato celebrandolo nel presente, come accennato, ma volgersi all’avvenire per fornire i frutti delle esperienze, delle storie, delle passioni alle generazioni future. È «il ventre dell’anima», diceva Sant’Agostino. Mentre San Tommaso la vedeva come «il tesoro e il posto di conservazione della specie».
Non è, dunque, come si vorrebbe oggi, il retrobottega di un trovarobe di ricordi, ma è energia dinamica, vitale che accompagna l’esistenza e ne amplia la capacità di comprensione davanti al nuovo. Tanto che Henri Bergson osservava che la memoria «non consiste nella regressione dal presente al passato, ma al contrario nel progresso dal passato al presente. È nel passato che noi ci situiamo di colpo».
Sulla trama dei ricordi si può innestare la costruzione di un destino; senza, ci si nega la possibilità di penetrare il tempo riducendolo a strumento del nostro spirito e della nostra intelligenza. La decadenza nella quale siamo immersi è tributaria anche del tramonto della memoria come elemento distintivo di comunità caratterizzate dall’assenza del ricordo del loro cammino perché scientificamente cancellato da chi aveva immaginato il «nuovo inizio» della storia dalla proclamazione della “morte di Dio”.
Il richiamo di Formichella è un gradevole impasto, seppure implicito, di ciò che è stato cancellato con ciò che prepotentemente vuole rivivere attraverso riti ed usi che si rivolgono alle generazioni più giovani attraendole con la narrazione delle tradizioni solopachesi. E si scopre in tal modo di come nei secoli passati, e fino alla metà di quello appena trascorso, sia pur con comprensibili varianti, ci si vestiva, ci si fidanzava, si percepiva l’amore, si viveva l’attesa del matrimonio che poi lo si nutriva giorno dopo giorno benché non sempre rose e fiori sbocciassero nel suo giardino di sensi e di sentimenti. La nascita e la morte erano improntati ad una sacralità che oggi ci appare incomprensibile, con i loro riti, le loro usanze, le gioie ed i dolori che venivano vissuti per lunghi periodi dopo gli eventi. E le feste, soprattutto religiose, erano il legame tra il mondano ed il celestiale, con rimandi metafisici degni di teurgie semi-pagane. Durante le feste la comunità si cementava: erano occasioni nelle quali parenti ed amici si riunivano attorno a mense allestite in allegria con il meglio che si possedeva, per lo più povere eppure seducenti perché “rare” nel corso dell’anno, e con il cibo si benedicevano la vita ed i prodotti della terra coltivati in proprio con attrezzi se non proprio rudimentali lontanissimi agli infernali meccani contemporanei.
Le informazioni sui piatti tipici che offre Formichella sono strepitose. Molte pietanze le abbiamo recuperate e compaiono sulle nostre tavole imbandite nelle festività maggiori, altre le abbiamo perdute e risultano quasi eccentriche “riscoperte” oggi alla luce della ricerca di prodotti genuini e non standardizzati.
Perfino le superstizioni e le credenze, con i canti agresti e le celebrazioni laiche che scandivano il passaggio delle stagioni non vengono trascurate in questo pregevole volume che ci dice da dove veniamo e come eravamo. Centrale nella vita solopachese era la vendemmia, dal momento che l’uva ed il vino erano prodotti tipici e di gran valore. “La campagna – scrive Formichella – si animava tutta e nei vigneti si riunivano per il lavoro parenti, amici, braccianti. Fra i filari delle viti, da un vigneto all’altro, echeggiavano gli antichi canti d’amore paesani, cori campestri, stornelli, mottetti vari. A pranzo una breve pausa, ma di sera, dopo la lunga , faticosa, ma gioiosa giornata, si festeggiava con laute cene e bevute in compagnia. Canti, suoni e balli allietavano la serata fino a notte fonda. Per tale occasione si beveva il miglior vino delle passate annate, che era stato conservato appositamente per questo rito conviviale”.
Tradizioni popolari in Solopaca è un libro che rende giustizia ad un borgo rurale la cui civiltà è il retaggio prezioso di chi si sente partecipe di una lunga avventura umana che data quasi mille anni, dai primi insediamenti nella parte alta del Paese ai nostri giorni. Secondo molti storici, Solopaca nacque come casale (centro minore o frazione) di Telesia, probabilmente dopo la distruzione portata alla città dalle incursioni saracene e dal successivo terremoto degli anni 846-848 d.C. A sostegno di tale tesi ci sono alcuni articoli degli Statuti di Telese, scritti tra il 1197 e il 1250 dal notaio Antonello di Cerreto Sannita.
Nel 1268 Solopaca, insieme con Telese, fu data da Carlo I d’Angiò a Guglielmo Belmonte, grande ammiraglio del regno.
In seguito al terremoto del 1349 e delle conseguenti nascite di mofete ed esalazioni di vapori sulfurei, Telese si spopolò incrementando lo sviluppo dei comuni vicini come Solopaca. Dunque origini antichissime rendono il borgo adagiato alle pendici del Taburno, un gioiello culturale che simboleggia la civiltà della nostra terra. È pertanto improprio stabilire con precisione quando è nato, per questo è prudente attenersi attorno all’anno Mille come tempo di identificazione della sua formazione e con essa dell’inizio di consuetudini che avrebbero sviluppato una tradizione.
Anche per questo il contributo di Formichella riassume il richiamo ad una storia che non deve perire e ad una una memoria che deve sopravvivere.
Già, la memoria. È il refrain di queste modeste considerazioni a corredo del lavoro di Formichella. Che mi porta a considerare che la memoria ha cominciato a svanire quando le ombre del sacro si sono ritratte alla nostra conoscenza e la rivelazione della povertà umana non ha armato le coscienze di fronte all’esposizione della sua nudità, ma ha convinto i maestri del pensiero ad ammantarla di orpelli fatui atti a dimostrare che perfino senza un passato, e dunque, senza il riconoscimento del Principio, poteva esserci un avvenire. Ecco i risultati dell’inveramento della menzogna nel popolo degli immemori. Le tracce del passato si sono cancellate, la didattica della Ragione non prevede l’immersione nella liquidità delle origini, il sogno del futuro è abrogato dalle consuetudini che sistemano nelle menti l’orrore della memoria soltanto come etereo simbolo di scarnificati predecessori destinati a essere dimenticati in pochi decenni. La cultura del sepolcro, insomma, è l’alibi per sostenere la fine della storia, e quindi della continuità dello spirito. Come se bastasse un fiore per chiudere la bocca alla voce dei millenni.
Perciò, trionfante l’oblio, quale religione della modernità, del tutto inconsapevolmente consumiamo emozioni, passioni, relazioni, sentimenti come insignificanti merci i cui avanzi sono destinati all’immondezzaio. Le discariche sono le metafore di quest’epoca; i rifiuti come produzione di risorse riassumono l’allegra disfatta di un’umanità che neppure per un istante si sente dolente, usata, macellata perfino. La tendenza alla rimozione è voluttuosa. Che si tratti di prodotti storici, è indifferente. Anzi, non è neppure un dettaglio, ma è così, indiscutibilmente. Senza il prima non può esistere il dopo. Ma il dopo probabilmente spaventa e allora è stupido anche soltanto immaginare che c’è stato un “prima”.
La cultura dell’evanescenza prepara il nichilismo, l’approdo al nulla giocando sulla devastazione della memoria fino a negarla perché così l’ossessione ad afferrare ogni cosa, usarla, gettarla, farla diventare rifiuto sollecita il consumo che solo genera passioni al suo livello, cioè a dire dolori e gioie che non durano. Finzioni, insomma.
Privi di memoria non dobbiamo fare i conti con noi stessi. Perché non dobbiamo tramandare nulla. E, dunque, siamo esentati dal coltivare obblighi con il passato. Negandoci questo possiamo essere liberi dall’ossessione del futuro. Noi, prodotti della civiltà, in realtà contiamo meno di ciò che consumiamo. E il fine che del tutto inconsapevolmente perseguiamo, per quanto orrendo, al punto di non ammetterlo quando ci viene fatto osservare, è la rimozione di noi stessi. L’oblio totale, assoluto, inappellabile.
La condanna della memoria, sopraffatta dalla dimenticanza, lascia sul campo macerie di ogni tipo, qualcuna l’ho ricordata. Ma il tesoro più grande che disperde è l’amore. Se non si ricorda che l’essere umano è amore incarnato, è più facile accanirsi contro di lui, stravolgerlo fino ad annientarlo, togliergli i rimanenti attributi spirituali e ridurlo a un meccano o, nella migliore delle ipotesi, a una istanza materiale giustificata dalla voracità con cui si avventa su ciò che la natura o il mercato gli mettono a disposizione. Ma l’amore è dono che non ammette scambio. La memoria dell’amore è la continuità nel donarsi fino all’estasi in alcuni casi, nella sublime accensione della carnalità secondo canoni normali, nell’avvolgere di carità i bisogni degli umili e dei disperati.



